
Limbadi, il 6 maggio si illumina per Maria Chindamo: memoria viva contro la ‘ndrangheta
Nel nono anniversario della scomparsa di Maria Chindamo, il luogo del delitto si trasforma in

In magistratura da maggio 1996, Giovanbattista Tona è uno dei massimo esperti di Beni Confiscati sul territorio nazionale. Lo abbiamo intervistato in occasione dei 25 anni dalla pubblicazione della legge in materia.
Dopo un quarto di secolo, tracciamo un bilancio sull’efficacia della legge sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. È utile?
Da quando i beni confiscati alla criminalità vanno riutilizzati a fini sociali 17.300 immobili sono stati destinati ad enti e ad associazioni e servono a perseguire scopi di pubblica utilità: all’incirca 3.000 all’anno. Certo ce ne sono altrettanti ancora da destinare; dobbiamo preoccuparci del fatto che le aziende destinate il più delle volte vengono liquidate e non proseguono l’attività; spesso passa troppo tempo tra confisca ed effettiva utilizzazione. Ma la legge del 1996 ha avviato un cammino e i risultati vanno misurati guardando a quanta strada si è fatta e a quanta se ne può fare. Negli ultimi dieci anni sono stati destinati beni in misura cinque volte superiore rispetto al periodo precedente. E questo potrebbe già darci un’idea che non si parte da fermi.
Come velocizzare il processo per la assegnazione dei beni ai destinatari finali?
Le norme sulla destinazione a fini sociali sono confluite nel 2011 nel codice antimafia, che è stato riformato nel 2017 dopo due anni di approfondito lavoro messo a disposizione del Parlamento dalla Commissione Antimafia, presieduta da Rosy Bindi. Da quel lavoro maturò l’idea che già l’amministratore giudiziario nella prima relazione dopo il sequestro dovesse impostare un modello di gestione funzionale alla possibile destinazione del bene o dell’azienda. Applicando queste disposizioni, diversi Tribunali stanno promuovendo anche forme di comodato dei beni agli enti e alle associazioni ai quali potrebbero essere assegnati. Sono prassi non ancora sufficientemente diffuse e ancora da perfezionare. Tuttavia sono quelle che, a legislazione vigente, evitano i danni derivanti dai ritardi nelle assegnazioni. Detto questo resta il problema dell’organico dell’Agenzia che ha il compito di gestire e destinare i beni confiscati, istituita nel 2010 dotandola irresponsabilmente solo di 30 dipendenti per occuparsi di migliaia di beni sul territorio nazionale, e che solo con la legge di bilancio del 2020 è stata effettivamente potenziata. L’organico previsto ora, ma ancora in parte da coprire, sarebbe di 300 unità. A fronte di 19.300 beni immobili e di 2.920 aziende in gestione. Le cose dovrebbero andare meglio ma fatti i conti, a regime, ogni dipendente avrebbe in carico 64 immobili e 10 aziende. E le confische continuano a ritmo incessante.
Nel caso di sequestro di un’impresa mafiosa, come fare per permettere agli amministratori di continuare ad amministrare quando le banche, appreso che è intervenuto lo Stato, chiudono le linee di credito?
Anzitutto vanno individuate le aziende che possono proseguire l’attività senza avvalersi di capitali illeciti e di prassi illegali; le altre vanno liquidate e, come prevede la legge, se le banche che le hanno finanziate non provano la loro buona fede, i debiti non vanno pagati. Quando l’azienda può proseguire, gli ammini-stratori giudiziari devono saper proporre alle banche degli affidabili piani industriali, approvati dai Tribunali, che dimostrino che dalla prosecuzione delle attività dell’aziendapotranno trarre vantaggio tutti i creditori. D’altro canto oramai le banche sanno che la legge impone che i pagamenti dei debitiprecedenti al sequestro non saranno pagati se non dopo che esse proveranno di non avere agevolato volontariamente o per scarsa diligenza le attività dell’imprenditore mafioso. Purtroppo però, nonostante anche recenti direttive della Banca d’Italia, abbiano sollecitato gli istituti bancari a tenere conto delle peculiari condizioni delle aziende in sequestro, ancora certi atteggiamenti non collaborativi sono duri a morire.
In base a quali criteri propone la rotazione degli incarichi nelle amministrazioni giudiziarie per evitare situazioni simili a quelle verificatesi a Palermo?
Il legislatore del 2017 ritenne di risolvere la questione con una norma- manifesto che stabiliva il limite di tre incarichi per ogni amministratore. Ma ha creato più confusione che rotazione. Che voleva dire tre incarichi? Tre beni o tre nomine? Un sequestro a carico di un soggetto che ricicla soldi della mafia spesso interessa molti beni. E, se si devono contare solo le nomine, l’incarico di gestire una rivendita di alimentari vale uno al pari di quello che ha ad oggetto una catena di supermercati? Sembrerebbe di sì. E poi: tre incarichi da uno stesso tribunale o tre su tutto il territorio nazionale? E gli incarichi conferiti dall’Agenzia si contano? La norma frettolosa ha portato a prassi cieche e variegate. Andrebbe ripresa la norma originariamente proposta dalla Commissione antimafia: ogni autorità deve conoscere numero e tipologia degli incarichi che un amministratore ha già; poi decide se nominarlo motivando specificamente perché ritiene che possa essere in grado di svolgerlo. Il tutto con un tetto massimo di incarichi, variabile a seconda del valore di ciascuno.
Come si può incentivare la cooperazione internazionale in materia di misure di prevenzione?
L’Unione Europea è oramai dotata di regole che consentono ad un Paese di individuare beni e sequestrarli in un altro Paese. Vanno implementate le prassi e il dialogo tra le autorità. Poi bisogna lavorare ancora con i Paesi extraeuropei, con i quali c’è ancora molto da fare ma la Convenzione Onu di Palermo è una buona base.
Se potesse riscrivere la legge 109 del ‘96, cosa cambierebbe?
Le disposizioni della legge del 1996 sono state già modificate e integrate almeno cinque volte in 25 anni. Altre riforme si invocano. Giusto. Io penso però che bisogna lavorare di più per cambiare le prassi.

Nel nono anniversario della scomparsa di Maria Chindamo, il luogo del delitto si trasforma in
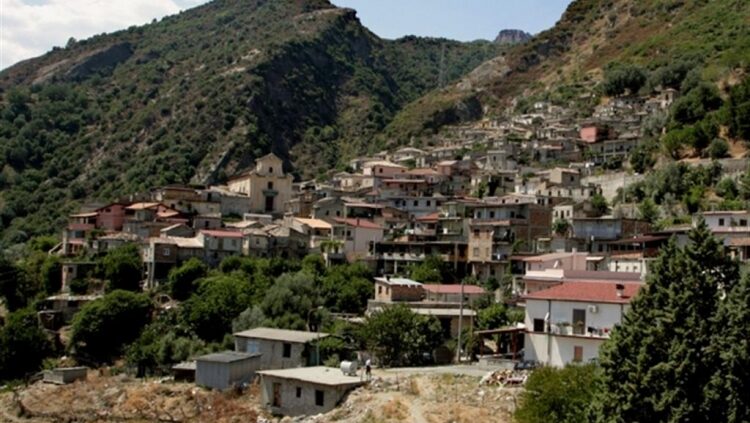
Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento

Alla seconda Conferenza nazionale sui beni confiscati, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha