
Tra misteri e verità negate: si riapre il caso De Grazia e delle navi dei veleni
Riaperto il caso delle “navi a perdere” grazie a nuovi fondi e a un’inchiesta giornalistica che riaccende interrogativi mai risolti.
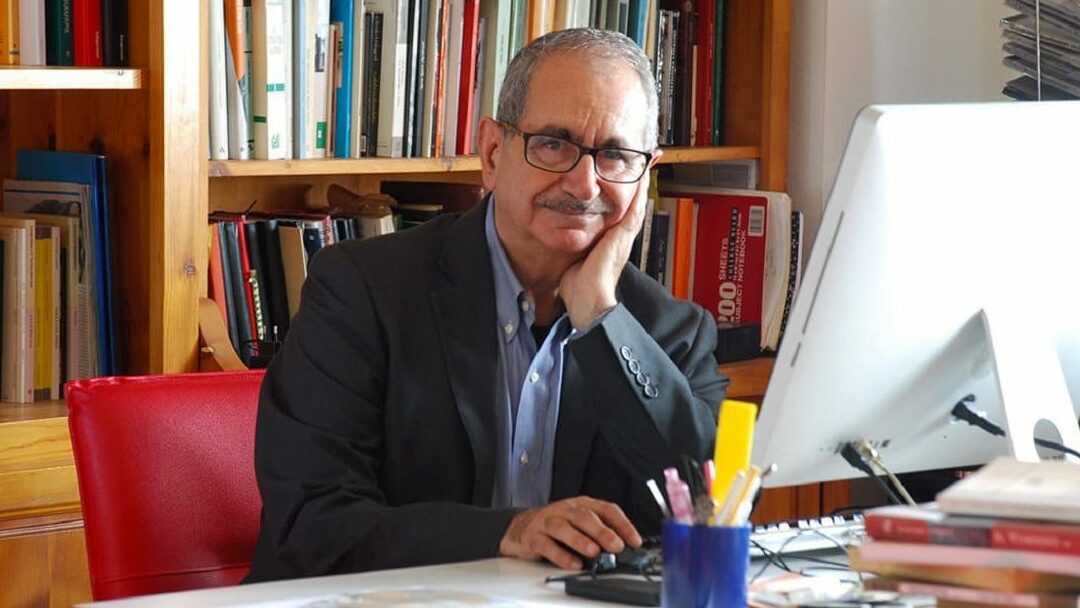
Non sempre la scelta di rimanere nella propria terra è la strada più facile. Può diventare un’opportunità per trasformare le difficoltà in sviluppo e resilienza. L’antropologo Vito Teti esplora il tema della restanza, proponendo un modello consapevole e politico per affrontare lo spopolamento e le sfide del presente e del futuro, con protagonisti i giovani.
In un mondo sempre più connesso e in continuo movimento, il diritto di restare assume una valenza cruciale, in particolare per i giovani calabresi che si trovano a dover scegliere tra migrazione e radicamento.
👇 Ascolta l'episodio di oggi del Podcast Good Morning Calabria con Vito Teti
Questo tema, tanto attuale quanto complesso, è stato esplorato con profondità dall’antropologo e accademico Vito Teti, che da anni indaga il concetto di restanza. Ne abbiamo parlato con lui.
Il verbo restare, complementare a partire, su cui ho riflettuto nei miei studi sull’immigrazione, non riusciva a restituire il senso di una scelta né la complessità del fenomeno che lega chi resta e chi parte. Da qui nasce il concetto di restanza che ha assunto una dimensione dinamica e responsabile, trovando risonanza nelle lettere, recensioni e messaggi che ricevo. Sono soprattutto i calabresi e i meridionali emigrati a identificarsi in questa parola, che racchiude il loro senso di colpa, il desiderio di tornare, l’inquietudine.

La restanza si configura come una forma di resistenza allo spopolamento, allo svuotamento dei luoghi, spesso legata al Sud, alla Calabria, ai piccoli paesi, ma in realtà riguarda anche le città, con i quartieri distrutti, o le isole, dove il desiderio di restare e di andare si intrecciano. Non è un fenomeno marginale o relegato a contesti arretrati: è il mondo stesso a porsi il problema di restare. Guerre, migrazioni e calamità ci mostrano come il diritto di restare sia tanto cruciale quanto quello di migrare. Papa Francesco lo ha espresso con forza: diritto di restare e diritto di migrare. Due diritti che si completano, per permettere a chi lo desidera di esprimere le proprie potenzialità, il proprio sapere, la propria voglia di costruire e migliorare nel luogo a cui sente di appartenere, senza essere costretto a partire.
Il concetto di restanza rischia di diventare uno slogan o un proclama strumentalizzato. Per me, deve essere un diritto da rivendicare e, in un certo senso, politicizzato: una politica della restanza o una restanza come politica. Chi vuole restare deve creare le condizioni per farlo. I giovani non vanno via per scelta, ma perché non trovano lavoro, servizi adeguati o luoghi abitabili.
PER APPROFONDIRE: Reggio Calabria, con i fondi del Pon Metro Plus nascerà un hub per start-up e PMI
Manca una sanità efficiente, chiudono uffici postali, negozi, biblioteche, cinema e teatri. In queste condizioni, restare diventa una sofferenza che spesso supera quella del partire, seppur verso luoghi sconosciuti. Altrove, però, ci sono condizioni favorevoli: università di prestigio, sanità adeguata, opportunità lavorative. Un esempio concreto è la Sicilia, dove uno studente su quattro, dopo il diploma, sceglie università fuori regione, non per mancanza di tradizione culturale o istituzioni valide, ma per la percezione di maggiori possibilità altrove.
I giovani che partono sono spesso istruiti, iperconnessi e competenti in tecnologia. Se queste abilità fossero applicate ai settori tradizionali del territorio, come l’agricoltura o la zootecnia, potrebbero generare opportunità inedite. Non si tratta di rinunciare al progresso, ma di portarlo dove serve. D’altronde, molti giovani sostengono che il lungomare di Reggio Calabria sia più bello del Duomo di Milano, e come dargli torto? Ma per restare servono investimenti, non solo infrastrutturali, ma anche in servizi, sicurezza e opportunità. Il Pnrr offre risorse importanti, ma se gestite male, saranno un’occasione sprecata. Interventi come la messa in sicurezza del territorio, delle scuole e dei centri abitati non solo prevengono disastri, ma generano lavoro per tecnici, artigiani e professionisti locali. Bisogna invertire la sfiducia che fa pensare che nulla possa cambiare.
Chi parte spesso mantiene un legame affettivo e culturale con la propria terra. Questi legami possono trasformarsi in opportunità di sviluppo per chi rimane, ad esempio attraverso investimenti o progetti di innovazione sociale. Creare reti tra chi è rimasto e chi è partito è essenziale per sviluppare sinergie che possano generare nuove possibilità economiche, culturali e sociali nei territori d’origine.
Cavallerizzo, piccolo centro di trecento abitanti, frana nel 2005. Miracolosamente, nessuno muore: nella notte il paese viene evacuato. Da quel momento inizia l’esodo. Le persone reagiscono con un attivismo straordinario, dando vita a una marea di iniziative per ricostruire. Emergono conflitti: c’è chi vuole restare nella casa natale e chi accetta di spostarsi.

Alla fine, il paese viene ricostruito vicino al vecchio abitato, ora deserto. Non è stato possibile ricostruire il vicinato tradizionale, ma con tutti i limiti è nata una nuova comunità. Questo spirito di resistenza è un esempio di restanza attiva e propositiva.
Le crisi possono essere momenti di svolta per immaginare e costruire un futuro diverso. Serve però una visione strategica, in grado di valorizzare le peculiarità dei territori marginalizzati. Investire in cultura, sicurezza, innovazione e servizi di base è il primo passo. Bisogna creare opportunità di lavoro e condizioni di vita dignitose.
La scuola è fondamentale, insieme alla famiglia e alle altre agenzie educative. È necessario che i giovani siano educati al valore della propria terra, ma anche alla possibilità di innovarla. Servono programmi scolastici che valorizzino le competenze locali, collegandole a un contesto globale. Non è solo una questione di conoscenze, ma di trasmettere valori come il rispetto, l’orgoglio per le proprie radici, e la capacità di immaginare un futuro migliore, proprio lì dove si è cresciuti.
Restare è faticoso, doloroso, forse è il grande viaggio della propria vita. Ma restare è anche un viaggio dentro se stessi, nella propria storia e nelle proprie origini. Oggi le difficoltà devono spingerci a rendere possibile ciò che sembra impossibile, a rendere vivibile ciò che appare invivibile. Restare in modo responsabile, etico, consapevole e aperto al mondo può dare gratificazioni e realizzazioni che altrove potrebbero non esserci.

Riaperto il caso delle “navi a perdere” grazie a nuovi fondi e a un’inchiesta giornalistica che riaccende interrogativi mai risolti.

Domani, domenica 27 aprile, torna in edicola e in parrocchia Avvenire di Calabria con un

Lo spettacolo è prodotto da Calabria dietro le quinte, in collaborazione con la compagnia Blu