
Dal Medioevo a oggi: rilettura sociologica di un’età di trasformazioni
Riscoprire la profondità delle relazioni umane che caratterizzavano quell’epoca può offrirci una lezione preziosa Il
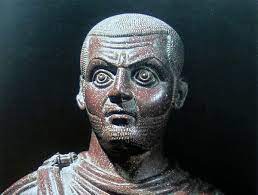
L'editto di Serdica fu emesso il 30 aprile 311 a Serdica (l'attuale Sofia, capitale della Bulgaria) dal Primus Augustus Galerio a nome del collegio tetrarchico che reggeva l'Impero romano. Con esso il cristianesimo otteneva per la prima volta, e ben due anni prima del più famoso Editto di Milano, implicitamente lo status di religio licita, ovvero culto riconosciuto ed ammesso dall'Impero.
Il 23 febbraio 303 (il 1056 ab urbe condita), in occasione della festa dei Terminalia, l'imperatore romano Diocleziano emanò, su proposta di Galerio, un editto persecutorio. L'editto prescriveva: l'abbattimento delle chiese e il rogo delle Sacre Scritture; la confisca dei beni ecclesiastici; il divieto per i cristiani di intentare azioni legali collettive; la perdita di carica e privilegi per i cristiani di alto rango che si rifiutassero di abiurare; l'arresto di alcuni funzionari statali. A quel tempo, Galerio rivestiva la carica di Cesare dell'Impero romano, la seconda autorità più importante dopo quella dell'Imperatore. Il 1º maggio 305, Diocleziano abdicò; Galerio, suo successore, continuò l'attività di persecuzione in Oriente fino al 311, quando, il 30 aprile, concesse ai cristiani il perdono, la libertà di culto e, implicitamente, lo status di religio licita. Galerio morì cinque giorni dopo.
Non perdere i nostri aggiornamenti, segui il nostro canale Telegram: VAI AL CANALE
Il 13 giugno del 313 d.C. venne promulgato l’Editto di Milano, noto anche come Editto di Tolleranza o Editto di Costantino, dal nome dell’Imperatore d’Occidente che ne caldeggiò la promulgazione, garantendo «anche ai cristiani, come a tutti, la libertà di seguire la religione preferita». Questo documento di più di 1700 anni fa è l’antesignano scrigno della libertà di culto. L’allora Imperatore d’Oriente Costantino I incontrò tra il febbraio e il marzo del 313 d.C. il suo omologo, Imperatore d’Oriente Licinio. All’alba di tale incontro pare ne sia scaturita la pubblicazione di un provvedimento con forza di legge, consegnatosi alla storia come il famigerato Editto di Milano. La storicità di detta promulgazione è stata oggetto di accesi dibattiti tra gli storiografi e gli studiosi del diritto, sebbene la veridicità dell’incontro tra i due Imperatori non sia mai stata messa in dubbio. Costantino e Licino, «avendo discusso tutti gli argomenti relativi alla pubblica utilità e sicurezza, fra le disposizioni che vedeva[n]o utili a molte persone o da mettere in atto fra le prime, [hanno] posto queste relative al culto della divinità affinché sia consentito ai Cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che ciascuno crede, affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità».

Riscoprire la profondità delle relazioni umane che caratterizzavano quell’epoca può offrirci una lezione preziosa Il
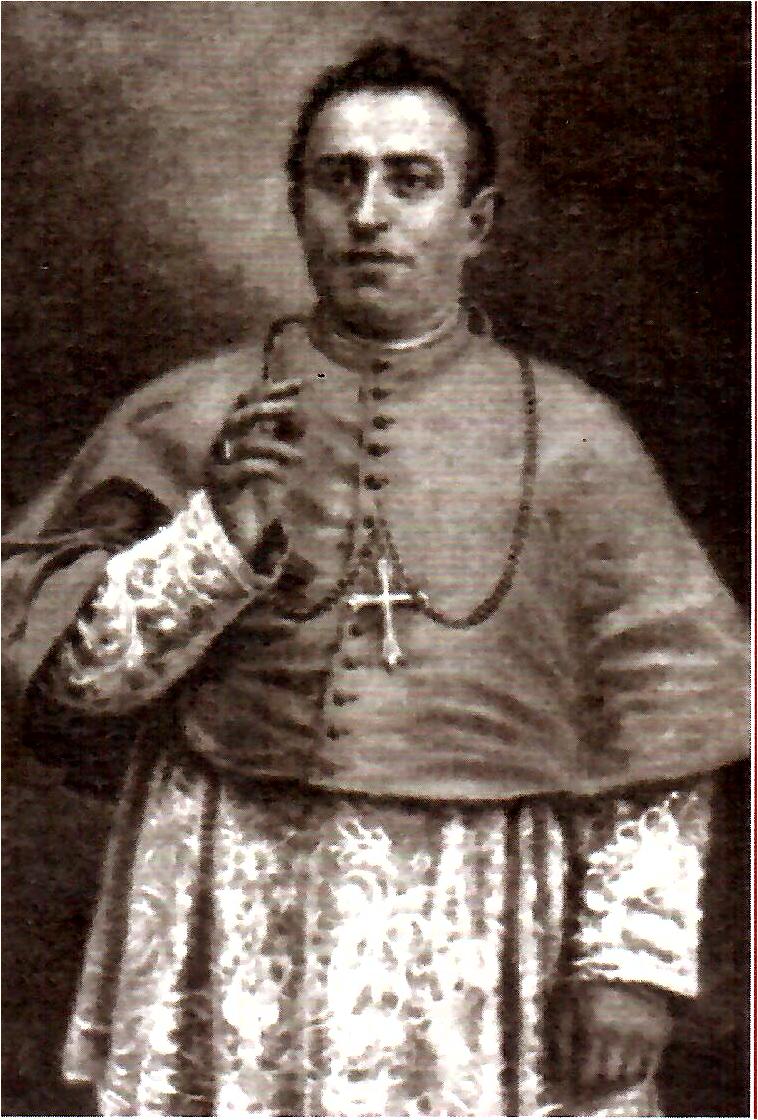
Presentato a Reggio il libro dello storico Focà che traccia un ritratto dell’importante figura ecclesiale reggina. Il presule fu vescovo di Mileto a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.
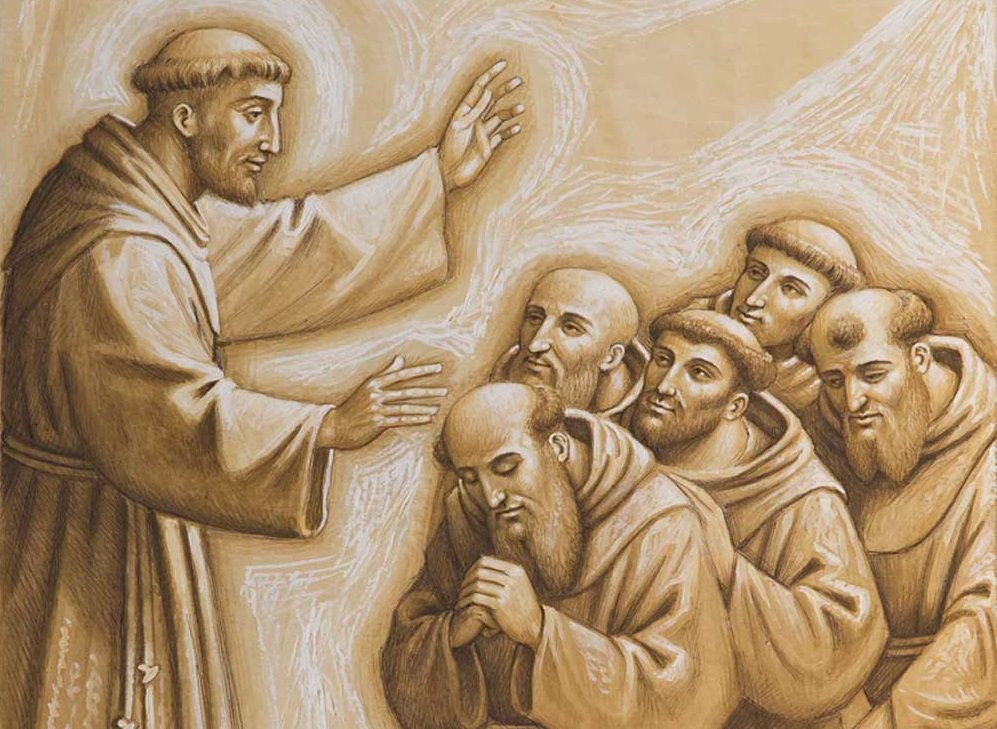
La storia che oggi vi raccontiamo affonda le sue radici agli inizi del ‘600 e riguarda l’odissea vissuta dai francescani a Reggio Calabria. Dal 1617 al 1929, il racconto di rovine e ricostruzioni che hanno coinvolto il convento dei francescani, la parrocchia del Crocefisso, l’arcivescovo D’Afflitto e un barone omicida.
Tags: Storia