
Il biondo di Trebisacce protagonista de “L’ingrediente perfetto”
Lo chef ha deliziato con la preparazione di un piatto di “chitarre all’arancia bionda tardiva
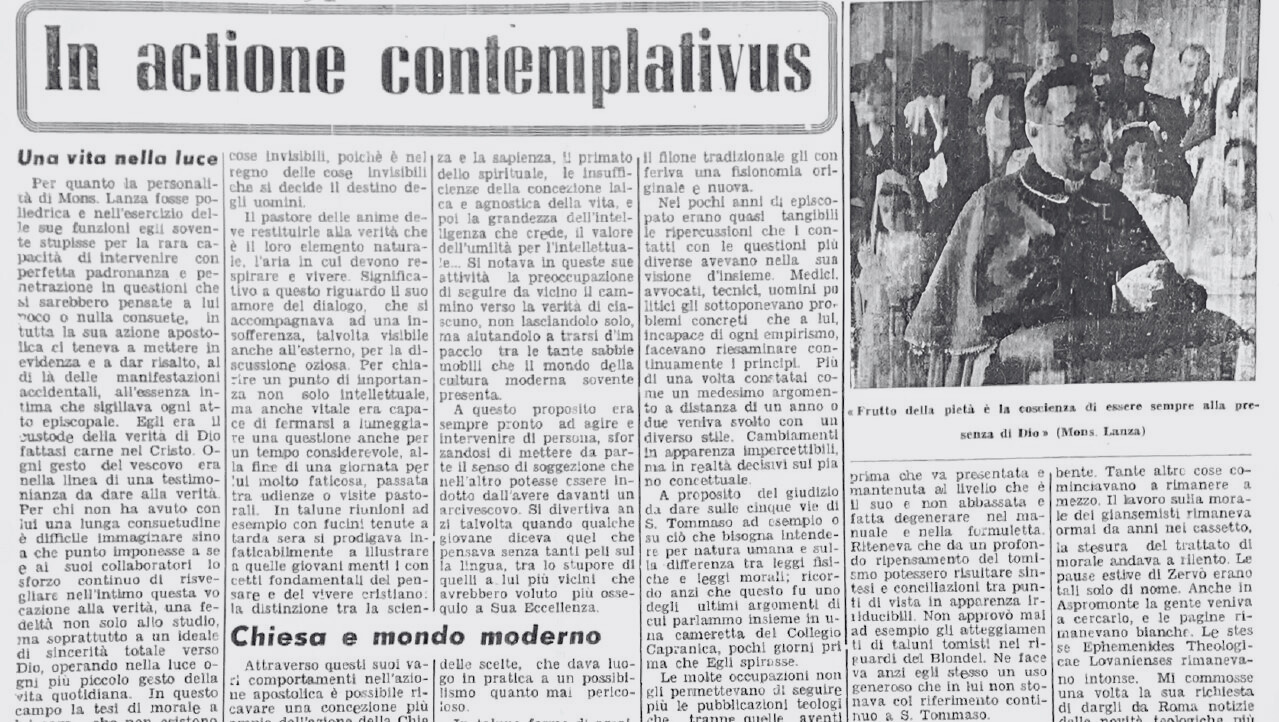
In occasione del 75° anniversario della morte di monsignor Antonio Lanza, Avvenire di Calabria, in collaborazione con il MEIC, ripropone ai lettori alcuni contributi storici che ne testimoniano la figura e l’eredità spirituale. Il secondo testo, che presentiamo oggi, è firmato da monsignor Domenico Farias ed è apparso su Avvenire di Calabria il 27 settembre 1960.
Nel contesto delle iniziative promosse dal Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic), dalla Conferenza episcopale calabra, dalla Fuci e dall’Istituto “Antonio Lanza”, il 75° anniversario della morte dell’arcivescovo reggino diventa occasione per rileggere il pensiero e il magistero di un vescovo che ha lasciato un’impronta indelebile nella Chiesa del Mezzogiorno.

Dopo il discorso commemorativo del cardinale Giuseppe Siri, pubblicato lunedì 31 marzo, proponiamo ora integralmente l’articolo In actione contemplativus (Contemplativo nell’azione), scritto da monsignor Domenico Farias, all’epoca già figura di primo piano nel panorama dell’impegno culturale cattolico. Il testo fu pubblicato a pagina 14 dell’edizione del 27 settembre 1960 del settimanale
Il testo di monsignor Farias è molto più di un ricordo: è una riflessione profonda sul significato del ministero episcopale, vissuto da monsignor Antonio Lanza come sintesi di azione pastorale e contemplazione evangelica. Il titolo latino In actione contemplativus restituisce con esattezza la cifra spirituale di un uomo di Chiesa che ha saputo coniugare pensiero e testimonianza, azione concreta e visione teologica, servizio e studio, con una straordinaria attenzione alla crescita spirituale dei giovani e del laicato.
PER APPROFONDIRE: Lanza e la sua Lettera guida su “I problemi del mezzogiorno”
Attraverso aneddoti, intuizioni e citazioni, Farias disegna il profilo di un pastore appassionato della verità, sempre in ascolto della realtà, ma radicato nelle sorgenti della fede. Una figura ancora attuale, capace di offrire oggi spunti preziosi per chi desidera vivere l’impegno ecclesiale come autentica vocazione alla santità nel mondo.
Per quanto la personalità di Mons. Lanza fosse poliedrica e nell’esercizio delle sue funzioni egli sovente stupisse per la rara capacità di intervenire con perfetta padronanza e penetrazione in questioni che si sarebbero pensate a lui poco o nulla consuete, in tutta la sua azione apostolica ci teneva a mettere in evidenza e a dar risalto, al di là delle manifestazioni accidentali, all’essenza intima che sigillava ogni atto episcopale. Egli era il custode della verità di Dio fattasi carne nel Cristo. Ogni gesto del vescovo era nella linea di una testimonianza da dare alla verità.
Per chi non ha avuto con lui una lunga consuetudine è difficile immaginare sino a che punto imponesse a sé e ai suoi collaboratori lo sforzo continuo di regolare nell’intimo questa vocazione alla verità, una fedeltà non solo allo studio, ma soprattutto a un ideale di sincerità totale verso Dio, operando nella luce d’ogni piccolo gesto della vita quotidiana. In questo campo la tesi di morale a lui cara, che non esistono nella vita atti umani concretamente posti che siano moralmente indifferenti, aveva modo di essere continuamente applicata. Tutto si doveva svolgere nella luce di Dio e nelle più piccole cose l’anima innamorata di Dio poteva introdurre miglioramenti e progressi, cari al Signore come l’obolo della vedova. Ricordo un suo elogio dato con la massima convinzione in un caso di nessuna importanza in apparenza. Il dirigente di una colonia estiva aveva trovato modo di utilizzare le latte vuote dei cibi in scatola che nelle altre colonie venivano sprecate. Una cosa da nulla, ma alla quale Egli diede subito rilievo e rilievo spirituale.
Se questo avveniva per le cose materiali si comprenderà quanto maggiori fossero le sue esigenze nel campo apostolico in senso stretto.
Ogni concezione dell’apostolato che non solo in teoria, ma anche in pratica non lo presentasse come lo annuncio alla verità di Dio ad anime impedite nelle tenebre dell’ignoranza o dell’errore era a lui estranea. La conversione e lo sviluppo della vita della grazia si svolgono nel più intimo dell’anima, ed ogni apostolo deve essere dotato soprattutto di occhi spirituali e di quella finezza soprannaturale senza cui non si può assolutamente seguire l’azione di Dio in mezzo agli uomini. Egli, che pure si impegnava nel venire incontro alle necessità materiali del suo gregge in un grado notevole e del resto assai noto, non si fece mai illusioni sull’influsso che tali interventi, pur necessari e doverosi, avrebbero avuto sul piano spirituale.
Era sua radicata convinzione che il mondo moderno soffrisse profondamente perché ormai immerso in una eredità di errore, segregato in una lontananza spirituale dalla Chiesa che solo un apostolato spirituale avrebbe potuto colmare.
Tra la Chiesa e il mondo moderno bisognava gettare un ponte di grazia e di cultura, di spirito soprannaturale e di intelligenza, di sapienza e di scienza. Dovere principale di ogni apostolo era quello di avere e di sviluppare il senso delle realtà spirituali, l’amore per le cose invisibili, poiché è nel regno delle cose invisibili che si decide il destino degli uomini.
Il pastore delle anime deve restituirle alla verità che è il loro elemento naturale, l’aria in cui devono respirare e vivere. Significativo a questo riguardo il suo amore del dialogo, che si accompagnava ad una insofferenza, talvolta visibile anche all’esterno, per la discussione oziosa. Per chiarire un punto di importanza non solo intellettuale, ma anche vitale era capace di fermarsi a lumeggiare una questione anche per un tempo considerevole, alla fine di una giornata per lui molto faticosa, passata tra udienze o visite pastorali. In talune riunioni ed esempio con fucini tenute una tarda sera si prodigava infaticabilmente a illustrare a quelle giovani menti i concetti fondamentali del pensiero e del vivere cristiano: la distinzione tra la scienza e la sapienza, il primato dello spirituale, le insufficienze della concezione laica e agnostica della vita, e poi la grandezza dell’intelligenza che crede, il valore dell’umiltà per l’intellettuale...
Si notava in queste sue attività la preoccupazione di seguire da vicino il cammino verso la verità di ciascuno, non lasciandolo solo, ma aiutandolo a trarsi d’impaccio tra le tante sabbie mobili che il mondo della cultura moderna sovente presenta.
A questo proposito era sempre pronto ad agire e intervenire di persona, sforzandosi di mettere da parte il senso di soggezione che l’altro potesse essere indotto dall’avere davanti un arcivescovo. Si divertiva anzi talvolta quando qualche giovane diceva quel che pensava senza tanti peli sulla lingua, tra lo stupore di quelli a lui più vicini che credevano voluto più ossequio a Sua Eccellenza.
Attraverso questi suoi vari comportamenti nell’azione apostolica è possibile ricavare una concezione più ampia dell’azione della Chiesa nel mondo moderno per riportarlo a Cristo? Direi di sì. E del resto quel che si rispecchiava ad ogni istante nel suo modo di fare più di una volta fu oggetto di considerazioni e riflessioni in colloqui avuti con lui, in preparazione di attività apostoliche di vario genere. Non nascondeva innanzi tutto il suo giudizio negativo per talune forme di apostolato. C’era da aspettarselo in taluni casi, quando ad es. criticava la leggerezza e l’improvvisazione applicate alle cose del Signore. Più difficili e sottili le ragioni delle sue riserve per talune concezioni dell’apostolato che pure erano, e sono anche oggi, molto in voga. A prima vista si rimaneva stupiti.
A proposito del movimento biblico e liturgico ad es. si comportava con molta circospezione. Conseguenza senza dubbio anche della preparazione teologica avuta negli anni giovanili. Egli stesso amava ricordare le insufficienze dei corsi biblici dei suoi tempi (che pur non erano molto lontani) e la necessità di impostazioni migliori. Ma non si può vedere in ciò la causa di talune sue riserve. Come ebbi modo di capire dopo un certo tempo, per lui la Bibbia e la Liturgia erano un pascolo prediletto. Ciò che temeva era che attraverso un movimento biblico-liturgico poco avveduto si introducesse di contrabbando nella Chiesa una forma di spiritualità nebulosa e vaga, inficiata di un segreto fideismo e incapace di essere la base di una santità concretamente perseguita nell’impegno quotidiano.
Più di una volta ebbe modo di raccontare un episodio occorsogli mentre era assistente di un gruppo di professionisti. Professore di morale, aveva proposto un corso di teologia morale per laici. Ci fu una levata di scudi generale e la proposta dovette essere accantonata. La cosa lo colpì. Egli ci vedeva un segno chiaro di spiritualità «presbite» (paragone a lui caro). Si vedeva e si amava Dio da lontano e non da vicino. Il cristianesimo così non si concretava in un servizio quotidiano, ma si perdeva nel vago del sentimento.
Un cristianesimo pauroso delle determinazioni doverose e delle scelte, che dava luogo in pratica a un possibilismo quanto mai pericoloso. In talune forme di arcaismi biblico-liturgici egli intravedeva o sospettava pericoli di evasioni spirituali. Preoccupazioni non infondate, come anche in questi ultimi anni abbiamo potuto constatare.
Nell’impostazione dell’apostolato nel mondo della cultura le sue preferenze andavano alla linea tomista, ma al riguardo aveva maturato una posizione sua personale che riprendendo il filone tradizionale gli conferiva una fisionomia originale e nuova.
Nei pochi anni di episcopato erano quasi tangibili le ripercussioni che i contatti con le questioni più diverse avevano nella sua visione d’insieme. Medici, avvocati, tecnici, uomini politici gli sottoponevano problemi concreti che a lui, incapace di ogni empirismo, facevano riesaminare continuamente i princìpi. Più di una volta constatati come un medesimo argomento a distanza di un anno o due veniva svolto con un diverso stile. Cambiamenti in apparenza impercettibili, ma in realtà decisivi sul piano concettuale.
A proposito del giudizio da dare sulle cinque vie di S. Tommaso ad esempio o su ciò che bisogna intendere per natura umana e sulla differenza tra leggi fisiche e leggi morali; ricordo anzi che questo fu uno degli ultimi argomenti di cui parlammo insieme in una cameretta del Collegio Capranica, pochi giorni prima che Egli spirasse.
Le molte occupazioni non gli permettevano di seguire più le pubblicazioni teologiche, tranne quelle aventi attinenza al suo trattato di morale, ma ancora una volta mi stupì la sua capacità di cogliere sul vivo le questioni, di scorgere le insufficienze di vedute tradizionali e di riparavi con una intelligenza più profonda dei primi princìpi onde poterli applicare con migliore successo.
Su questo punto egli era di grandi esigenze. Il tomismo era per lui essenzialmente sapienza, filosofia prima che va presentata e mantenuta al livello che è il suo e non abbassata e fatta degenerare nel manuale e nella formuletta. Riteneva che da un profondo ripensamento del tomismo potessero risultare sintesi e conciliazioni tra punti di vista in apparenza irriducibili. Non approvò mai ad esempio gli atteggiamenti di taluni tomisti nei riguardi del Blondel. Ne faceva anzi egli stesso un uso generoso che in lui non stonava col riferimento continuo a S. Tommaso.
Col passare del tempo mi divenne sempre più chiaro che all’approfondimento e all’affinamento della sua visione, e quindi della sua azione cristiana, contribuiva in misura assai rilevante non solo un’esperienza sempre più vasta del mondo di oggi, ma soprattutto il maturarsi interiore della sua vita spirituale. Una sfera della quale sarebbe, oltre che indiscreto, presuntuoso voler parlare. Egli era a tal riguardo di un’estrema sobrietà nell’effondersi.
Molte cose trapelavano però con sufficiente chiarezza alle anime che erano guidate spiritualmente da lui o che hanno avuto la fortuna di seguire per diversi anni ritiri spirituali o corsi di esercizi. La sua visione teologica della vita, intellettualmente robusta e solidamente fondata su un sano apprezzamento delle capacità della ragione, ebbe modo di arricchirsi e affermarsi sempre più, sollecitata e stimolata da queste due grandi forze: un apostolato dinamico e vasto che presentava situazioni continuamente nuove e un’intimità con Dio che agiva come un’energia crocifiggente e purificatrice, che riportava anch’essa sempre più radicalmente all’unum necessarium.
Le due forze, dato il suo modo tutto spirituale di concepire e attuare l’apostolato, erano intimamente fuse e si richiamavano a vicenda in una sintesi che era il fondamento e il coronamento, l’alfa e l’omega, di quello che potremmo chiamare il suo senso della Chiesa.
Nell’idea e nella realtà della Chiesa tutti i conflitti e le tensioni si placavano, e i talenti più diversi che in lui urgevano avevano modo di esprimersi ed essere esercitati senza generare confusioni o dispersioni. L’ex professore, il filosofo, il moralista, l’acuto osservatore di uomini e di società e tanti altri suoi aspetti andarono sempre più intimamente coordinandosi nell’unico munus del servus fidelis super familiam Domini constitutus.
Il pasce agnos meos si faceva sempre più assorbente. Tante altre cose cominciavano a rimanere a mezzo. Il lavoro sulla morale dei giansenisti rimaneva ormai da anni nei cassetti, la stesura del trattato di morale andava a rilento. Le pause estive di Zervò erano tali solo di nome. Anche in Aspromonte la gente veniva a cercarlo, e le pagine rimanevano bianche. Le stesse Ephemerides Theologicae Lovanienses rimanevano intonse.
Mi commosse una volta la sua richiesta di dargli da Roma notizie delle novità teologiche più importanti. Gli altri elogiavano sempre più la profondità dei suoi interventi in incontri e convegni, ma egli era sempre meno soddisfatto.
Quando qualche giovane intellettuale incalzava ponendo difficoltà e problemi nuovi, egli, pur sgombrando il terreno dagli intralci più pericolosi, si inoltrava meno nelle questioni specifiche. Una volta mi disse: «Tutto un mondo sta crollando. Sono necessarie nuove e più salde costruzioni, ma nel frattempo sono necessarie anche le baracche per dare un tetto alla gente. L’interessante è che non si edifichi sulla sabbia».
In tutta la vita aveva dato la priorità alla sua missione sacerdotale, ma negli ultimi anni la compenetrazione di cultura e sacerdozio si fece più intima. La sua teologia si andò sempre più affinando e spiritualizzando. Aveva riscoperto S. Francesco di Sales e ne parlava con commossa partecipazione. Si sentiva sempre più chiamato alla paternità delle anime e aveva piacere che le attività culturali le svolgessero altri sotto la sua guida.
Avrebbe desiderato tante, e tante altre braccia, come diceva a proposito della scarsità delle vocazioni. Insisteva sulla docilità e la docibilità senza cui non si può essere uniti al vescovo e salvare l’unità della Chiesa. Accettava i lavori più pesanti.
Lo vedevo venire talvolta a Roma senza segretario, uscire il mattino presto e rientrare quando non si era già finito di pranzare, con la borsa piena di carte, di pratiche diocesane, come un prete qualsiasi. Così stanco che esitavo persino a parlargli, nonostante la gioia che dalla conversazione con lui derivava.
Mi ritornava in quelle circostanze in mente la frase di una signora austriaca protestante convertitasi al cattolicesimo e piuttosto delusa del mondo liturgico romano. Eravamo al pontificale di S. Agnese e Mons. Lanza celebrava; alla fine lei se ne esce in questa ingenua frase: «Finalmente ho visto un Vescovo».
Sac. DOMENICO FARIAS

Lo chef ha deliziato con la preparazione di un piatto di “chitarre all’arancia bionda tardiva

Lo yacht di lusso attracca nel porto cittadino con il suo carico di passeggeri internazionali, accolti tra cultura, tradizione e simboli dell’identità reggina.

L’esperienza è stata resa ancora più coinvolgente grazie a laboratori sensoriali e attività interattive Un